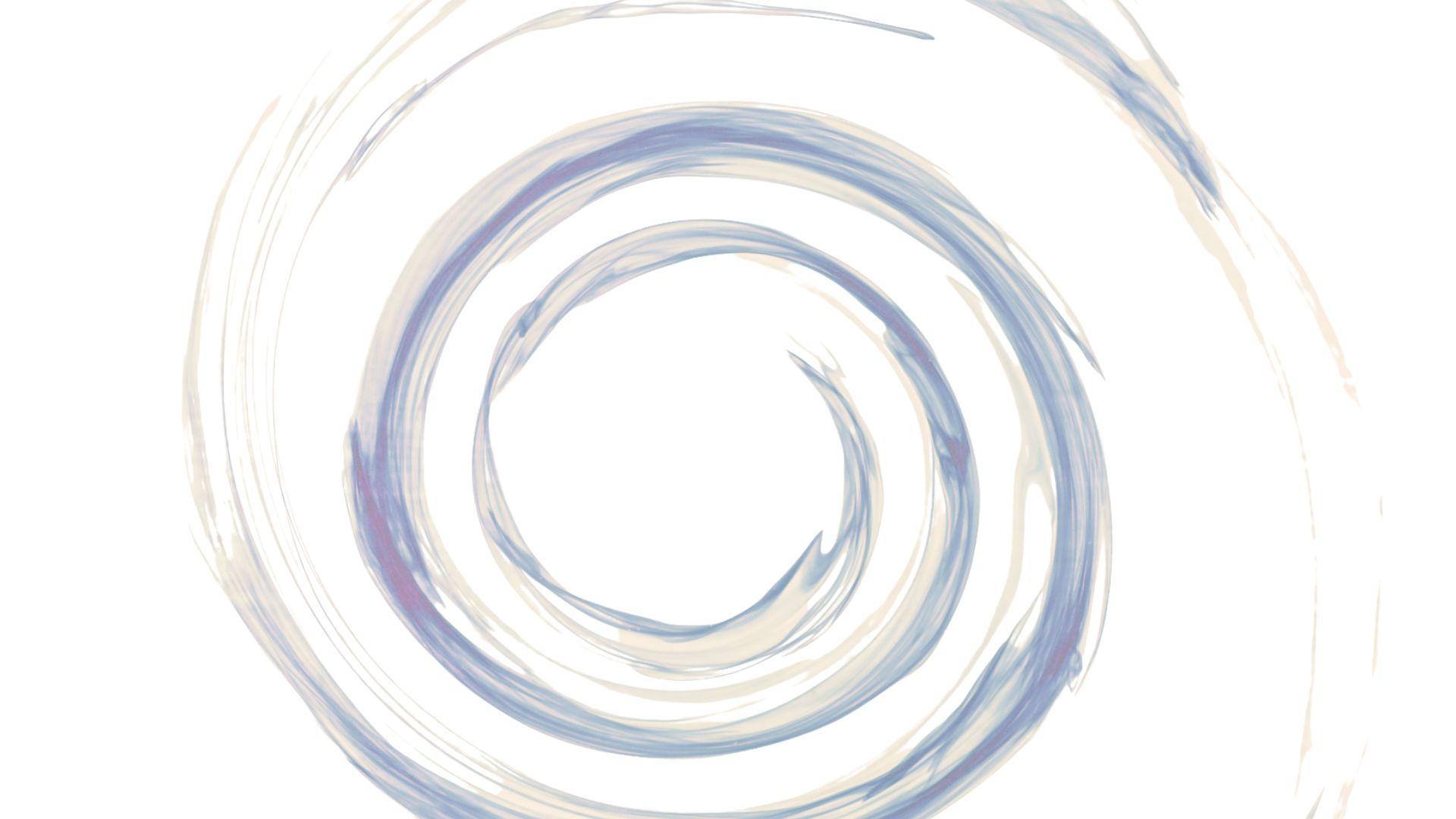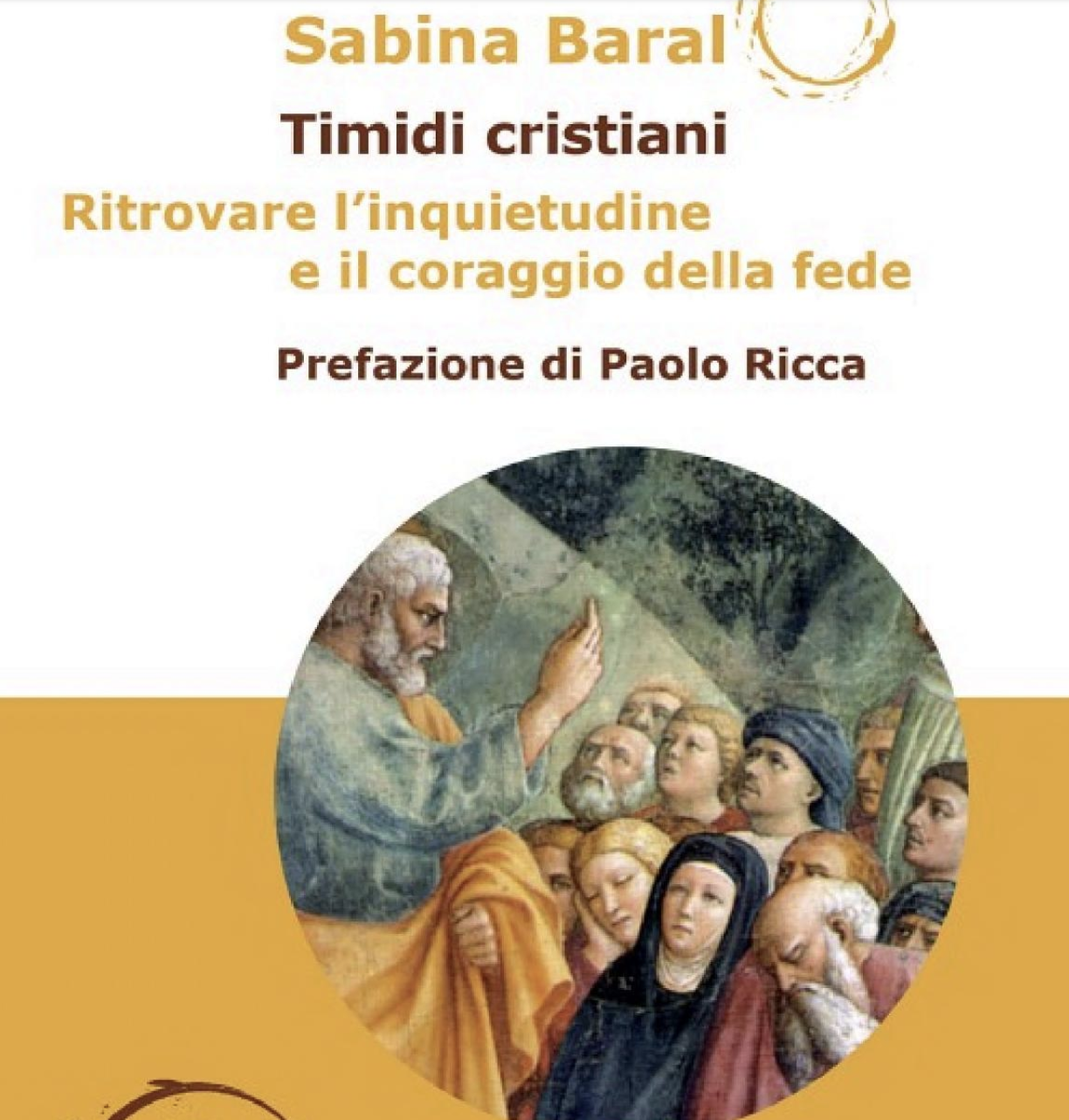Il Salmo 111
La riflessione sul tema "La Tua giustizia è giustizia eterna", sentenza-titolo del convegno giovanile dell'AEC tenutosi presso il Monastero di Camaldoli (26-28 luglio 2024), ha ribadito la fecondità del dialogo interreligioso. Massimiliano Boni (ebreo), Donata Horak (cattolica) ed Emanuele Campagna (evangelico) hanno esplorato la giustizia divina come invito al cambiamento sociale e come evoluzione relazionale della pena. Dal pulpito evangelico è emerso con forza il bisogno di accogliere il testo biblico non come mero lascito storico, ma come presente di Dio per il qui e ora.
Il concetto di giustizia nella tradizione evangelica è inerente alla dottrina della giustificazione e riflette l'intero spessore della riflessione ecclesiologica. In questa stratificazione di calchi semantici, la dialettica è sia diacronica (l'accoglienza dei lasciti dei padri) che sincronica (l'ampia messe di tendenze metodologiche novecentesche). In questa pluralità di approcci si impone una lezione su tutte: la parola della chiesa è una parola penultima. Il nostro studio si inserisce in questo filone con un commento del Salmo 111: la giustizia è l'esito di una partnership autentica tra Dio e l'essere umano in assemblea.
L'Architettura Sacra del Salmo 111
Il Salmo 111, un inno sapienziale e liturgico, non è tanto un inno di lode quanto un vero e proprio CREDO (al pari dello šemac isra’el e del Simbolo apostolico). La sua tesi di fondo è che la testimonianza epica dell'amore redentore di Dio dà vita eterna.
Il salmo si articola in: un'apertura di gratitudine e ricerca delle opere dell’Eterno (vv. 1-3); una strofa centrale che esplicita la tsedaqah (giustizia), rievocando l'epopea esodica, i prodigi e l'alleanza mosaica (vv. 4-9); e una chiusa dove le opere giuste dei retti sono celebrate come forma di sapienza eterna (v. 10). La narrazione suggerisce l'immagine di una spirale a doppia elica (celeste e terrena) che si avviluppa attorno all'alleanza, fondendo la giustizia del Signore che salva e il godimento qui e ora della salvezza.
Il componimento nasconde, sotto l'apparenza di una filastrocca alfabetica (procedimento mnemotecnico), una preziosa intelligenza letteraria. L'acrostico è un vincolo che, una volta sciolto dagli automatismi dell'ordine, rivela il valore del lessico. Come una "pepita non ancora sgrassata dalla terra," il testo esige una lettura attenta che non si fermi alla prima impressione.
L'Esigenza di una Lettura Intensa: Terep e la Giustizia
Questa poetica richiede una lettura piēl (concentrata, insistente). Un esempio lampante è la selezione lessicale al verso 5 [TET]: terep . Questo vocabolo, tradotto genericamente come "cibo," significa letteralmente rapina, bottino, preda (di una vittoria militare) o provvista.
Il senso di bottino di guerra risuona anche nel verso 6, dove Dio dona "l’eredità delle genti," tema su cui si è misurata la riflessione deuteronomica (cfr. Giosuè 24:13). La parola terep evoca il corpo supposto dilaniato ( trp ) di Giuseppe (Genesi 37:33), patriarca legato all'Egitto. In questo contesto, terep si rivela un sigillo dell'affidabilità del patto ( berit ): ciò che sembra terrore (la presunta morte di Giuseppe) inaugura, in realtà, una nuova storia di alleanza e salvezza per l'intera comunità di Israele. Giuseppe fu lì il cibo che salva.
Simbolismo Culturale: L'Alleanza con l'Antico Egitto
Per risalire alle fontes del Salmo, è necessaria un'analisi comparata con le tradizioni del Vicino Oriente Antico. Il mistero dell'area semantica cuore (in rapporto a lode, giustizia, memoria e alleanza) non è esclusivo dell'etica mosaica, ma è ben attestato nell'Antico Egitto, dove il cuore rappresentava la personalità e la sintesi di coscienza e sentimento.
L'egittologo Jan Assmann spiega questo intreccio complesso con i miti della morte. Nel mito più recente, la trasfigurazione del defunto è possibile solo dopo aver superato la prova della Macat (termine concetto per verità-giustizia-ordine): il cuore, leggero come una piuma, testimoniava l'impegno autentico nelle sue opere relazionali. Se il cuore risultava gravato dalle macchie del male, il defunto scompariva per sempre (la seconda morte).
Il mito più antico (simboleggiato dal dilaniamento di Osiride) drammatizza la sopravvivenza alla morte mediante la ricostituzione del corpo (opera di Iside) e il processo giudiziario contro Set (la morte). L'onere della prova in questo caso ricade sull'accusatore (Set). Vince il morto che, reintegrato nell'ordine dell'essere, è giustificato e insediato come sovrano.
Il Salmo 111, nella sua cronologia post-esilica, accoglie il vocabolario e il simbolismo dei miti egizi. Il nesso tra berit (il patto mosaico) e la nozione di guida (dal proverbio egizio: l’uno vive se l’altro lo guida ) svela il significato di giustizia-lode per sempre ( lacad ): essa non solo rompe la barriera del tempo (il fu è rimembrato nell'ora come presente), ma anche quella dello spazio, trasformando l'orizzonte sensibile in un memoriale della vita per il qui e ora .
La Giustizia come Partnership e Terapia
La conclusione è teologica ed esistenziale: la postura del retto, cioè del temente Dio, è quella di chi loda con il giusto raccoglimento di fronte al ricordo anamnestico dei prodigi dell'Eterno. Ciò comporta una partnership Dio-Essere umano autentica in cui i due contraenti attendono al proprio ruolo.
La giustizia-ricordo del credente è una testimonianza su due piani: quello liturgico di lode dei prodigi di Dio, vissuti nella comunità dei ben intenzionati ( ekklesia/qahal ), e quello sociale di attuazione sapiente della Legge. La rettitudine e la sapienza in funzione del timore dell'Eterno rimandano a un'etica attuativa che trova nell'incontro amorevole in assemblea il suo fondamento (v. 2b: "Oggetto di ricerca per coloro che le amano").
L'incontro amorevole di lode in assemblea, vincolo dell'alleanza per sempre tra l'essere umano/Chiesa e il suo Dio-leader, è una proclamazione dell'esistenza di Dio a discapito della morte. Dio, lodato per l'opera sua, è vivente oggi e qui, così come fu lì e allora. La giustizia è la promessa del credente in assemblea di esserci per l'altro – l'Eterno e la comunità – in equa prossimità, soddisfacendo il bisogno fondamentale di comunità. Il Salmo 111, omettendo i Patriarchi, indirizza l'alleanza sui vincoli di lealtà diretta e imprescindibile al momento presente della partnership : Dio è il partner dell'essere umano così come l'essere umano lo è di Dio.
Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *